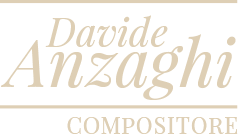La mannaia della spending review è calata implacable: recidendo molte teste incoronate. Duole, duole molto osservare come la nostra classe dirigente – musicalmente analfabeta – non si curi della musica colta. Se non per sancirne la espulsione dalla comunità.
Ciò premesso occorre anche ragionare sulle nostre responsabilità. Compositori e dirigenti di stagioni musicali (di musica d’arte contemporanea) non s’interrogò opportunamente sulla carenza media di pubblico. La predetta carenza aveva un duplice significato: non era ovviamente ascoltata dai grandi consumatori di musica ma non era “ascoltabile” in assoluto. Discendeva, quella musica d’avanguardia, da premesse ideologiche autoreferenziali che garantivano solo se stesse ma non la fruibilità degli esiti da essa scaturenti: molti non avrebbero negato la loro attenzione alla musica nuova. Purché “ascoltabile”. Le poetiche ebbero il sopravvento sulla poesia.
Vivevamo in un Paese che nelle sole Marche contava quasi 400 teatri d’opera. Dove sono finiti i frequentatori di quei teatri? Chi assisteva all’opera dal loggione era paragonabile al telespettatore di San Remo?
Un protocollo valutativo che assegna il 30% alla quantità di pubblico è insieme blasfemo e illuminato. Blasfemo quando sancisce la superfluità della “qualità”. Illuminato perché costringe compositori e operatori a porsi il problema della cospicua assenza di pubblico ai concerti di nuova musica non commerciale.
La soluzione non è Giovanni Allevi ma neppure Darmstad. Non avere enunciato il problema; avere ignorato l’apartheid e il solipsismo della nuova musica colta non è stata una strategia avveduta.
Alla nuova musica colta non competono gli stadi. Ma neppure le catacombe.